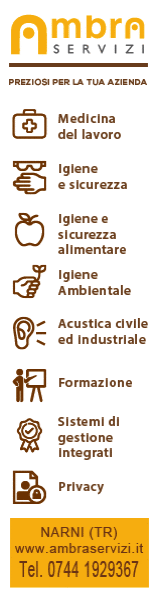Dal volume ‘Ferentillo segreta – I luoghi dell’arte e dello spirito’, lo storico Carlo Favetti ci porta indietro nei secoli del primo cristianesimo in Valnerina, al tempo del Giubileo. Chi percorre quel piccolo corridoio con fede e preghiera, acquista l’indulgenza plenaria perpetua. Una bolla pontificia del XII secolo ne certifica l’autenticità. Si tratta di una caratteristica presso la chiesa abbaziale di San Pietro in Valle. Ma andiamo con ordine.
Il tutto si svolge nel transetto di sinistra che si presenta di ampiezza esigua per altezza rispetto a quello di destra (dove sono le tombe degli Ancaiani e di Faroaldo che tratteremo in altra occasione). Le pareti sono coperte da uno spesso strato di intonaco dove emergono alcune tracce di affresco. Questo è il luogo più importante a livello storico e sacro di tutto l’edificio.
Tra l’intonaco il dipinto è raffigurato il duca longobardo Faroaldo che dorme nel suo letto: lo vegliano i soldati, mentre sogna l’Apostolo Pietro. Il dipinto è stato realizzato da un pittore umbro, probabilmente un locale. Alcuni attribuiscono a Pier Marino di Giacomo di Castel San Felice, ma – secondo Favetti – si accosta più ad un tifernate tardo seicentesco. Il pavimento di questo parte del transetto è risolto in lastre di pietra irregolari e tra esse, una lapide in marmo romana del IV secolo a.C. recante la seguente incisione: CEIS/TITUR/VIANV/IDEN.
Sulla parete si apre la porta che accede all’interno del campanile. Questo era il primo locale dell’originaria e più ampia sacrestia, la quale fu abbattuta ai primi del ‘900. Di questi locali fu recuperato un dipinto in affresco che era collocato in una lunetta. Il dipinto, ora esposto sulla navata centrale della chiesa, raffigura una crocifissione: al centro è collocato il Cristo, alla sua sinistra i santi Benedetto, Girolamo e la Madonna; alla destra la Maddalena in ginocchio, l’evangelista Giovanni, Santa Scolastica, sotto si distingue la dedica e la data T. ANCAIANUS ….E…..SCOLASTICA 147 (1470). Opera attribuita a un pittore della cerchia del Maestro di Eggi. Una scuola, questa, che viene riscontrata in uno degli affreschi più importanti in questo luogo, come quelli che coprono tutta l’abside centrale.
Il cosiddetto Maestro di Eggi, attivo in Valnerina e nello spoletino dal 1435 al 1451. Nativo di Eggi. A lui si attribuiscono alcuni affreschi presso la chiesa di San Severo (Spoleto), nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo, a San Michele Arcangelo di Eggi, nella chiesa di San Valentino di Scheggino, nella chiesa della Madonna del Rosario a Terria. A Piedipaterno eseguì un trittico presso la chiesa dell’Eremita (scomparso), presso la chiesa di San Francesco a Vallo di Nera. Della sua scuola sono opere a San Giovanni a Borgiano e a Santo Stefano di Matrignano.
 Qui a San Pietro in Valle sono attribuiti il Cristo Pantocratore tra angeli, Madonna col Bambino tra angeli santi, tra cui San Paolo, San Benedetto e altri santi e monaci benedettini risalenti al 1445. Ma andiamo nel vivo: nel transetto è collocata la prima abside che per la sua caratteristica inusuale nasconde particolari interessanti, dati appunto dalla testimonianza viva della presenza dei due santi eremiti. La superficie del nicchione è tutta affrescata, al centro la Madonna in trono col Bambino, ai lati Santo Stefano e San Pietro, due angeli sostengono il velo della Madonna mentre il terzo, collocato nella calotta absidale sorregge un cartiglio dove e scritto: VIRILITER AGE ET COMFORTER CO….IMPRETECN…CITO ….ENIM….LAB… sulla mano destra del Bambino Gesù pende un altro cartaio che mostra la seguente scritta: EGO SVM. Nella fascia inferiore si legge: S. JOANNES ….MCCCCLII HOC OPVS FECIT FIERI FRATER LAVRENTIVS ….PRO REMEDIO ANIMAE SUAE SUORVM MORTUORUM. L’affresco termina in basso, con la raffigurazione degli eremiti che percorrono il sentiero che li condurrà nella grotta, nel fitto bosco e vicino al ruscello.
Qui a San Pietro in Valle sono attribuiti il Cristo Pantocratore tra angeli, Madonna col Bambino tra angeli santi, tra cui San Paolo, San Benedetto e altri santi e monaci benedettini risalenti al 1445. Ma andiamo nel vivo: nel transetto è collocata la prima abside che per la sua caratteristica inusuale nasconde particolari interessanti, dati appunto dalla testimonianza viva della presenza dei due santi eremiti. La superficie del nicchione è tutta affrescata, al centro la Madonna in trono col Bambino, ai lati Santo Stefano e San Pietro, due angeli sostengono il velo della Madonna mentre il terzo, collocato nella calotta absidale sorregge un cartiglio dove e scritto: VIRILITER AGE ET COMFORTER CO….IMPRETECN…CITO ….ENIM….LAB… sulla mano destra del Bambino Gesù pende un altro cartaio che mostra la seguente scritta: EGO SVM. Nella fascia inferiore si legge: S. JOANNES ….MCCCCLII HOC OPVS FECIT FIERI FRATER LAVRENTIVS ….PRO REMEDIO ANIMAE SUAE SUORVM MORTUORUM. L’affresco termina in basso, con la raffigurazione degli eremiti che percorrono il sentiero che li condurrà nella grotta, nel fitto bosco e vicino al ruscello.
L’affresco affianca il corridoio dietro l’altare, dove i fedeli, pregando, varcano in entrata da un ingresso più ampio a uno di uscita più stretto. E’ in questo passaggio che si riceve l’indulgenza dei peccati sull’esempio dei santi Eremiti. Tutti i dipinti in questa abside sono di ‘scuola senese’. Questo altare è detto ‘di Lazzaro e Giovanni’ (il sarcofago che lo compone è formato nella parte alta dal contenitore che accolse in origine i corpi dei due eremiti). Il sarcofago forma una specie di ambulacro. Sulla parte destra del sarcofago, un’apertura con grata dove sono visibili alcune reliquie dei santi.
L’insieme dell’altare è un assemblamento di più pezzi dove un altro sarcofago romano misura 200×28 centimetri, al centro è raffigurato il defunto affiancato da due vittorie alate; alla sinistra è scolpita una scena conviviale, a destra una scena di caccia. Altro sarcofago, di dimensioni più ridotte (188x48x48 cm) con striature e, al centro, l’immagine clipeata del defunto sotto due cornucopie. L’urna è stata datata III sec. d.C. mentre il coperchio IV sec. d.C.; gli archi che sorreggono il tiburio presentano, anch’essi, decorazioni in affresco.
A sinistra dell’abside troviamo dipinti con San Bernardino e San Paolo e una monaca con sotto la scritta VIRGO… e un altro monaco con libro in mano sotto la scritta: LAZARVS ABBAS S.PETRI. Molto probabilmente questa era la primissima e antichissima chiesa, edificata da Faroaldo, quando grazie al sogno incontrò nell’asceterio i due eremiti Siri. Infatti, esternamente, nella stessa direzione è situata una piccola porta murata (sicuramente l’originario ingresso). Questo è il punto centrale e primario di tutta la costruzione, di quello che accadrà dal IX secolo, la più imponente chiesa abbaziale. Questo il fulcro, la parte più sacra, dove viene raffigurato e conservata la genesi dell’abbazia.