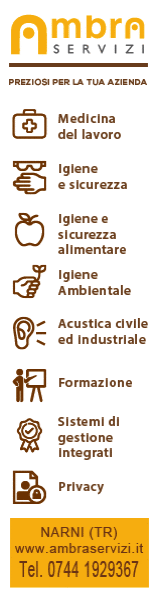di A. V.
Nella bella cornice del Cenacolo San Marco, lunedì sera, è stata presentata l’ultima fatica letteraria di Igea Frezza Federici. Il libro si intitola ‘Le cucine della memoria’, un nome significativo che fa subito capire che l’intento dell’autrice è raccontare la tradizione e la cultura del cibo in Umbria.
Pomeriggio con l’autore È stata la Fidapa, Federazione italiana arti, professioni e affari, a organizzare questo interessante pomeriggio con l’autore. A presentare l’evento Ada Urbani, presidente della federazione e la socia Maria Rita Chiassai. Sul palco, insieme a Igea, Massimo Palombi in veste di presidente onorario dell’Associazione degli umbri e Giuseppe Fatati, in qualità di direttore del centro studi dell’Accademia italiana della cucina, per la delegazione di Terni. Quindi, da un lato, un uomo politico impegnato però anche nel far conoscere le tradizione delle nostre terre, e dall’altro un medico, specialista della buona alimentazione, ma anche amante della buona cucina.
ADA URBANI RACCONTA IL POMERIGGIO CON IGEA – VIDEO
L’autrice Igea è una ‘ragazza’ di 90 anni e mezzo. Una «casalinga che si occupa di cose scientifiche», come si è definita lei stessa. Autrice di moltissimi libri e collaboratrice di molti giornali regionali e locali è da sempre impegnata nel tema della ‘memoria’. E questo suo ultimo libro continua a ‘scavare’ nella stessa direzione.
La memoria Questa volta come protagonista della sua storia, Igea ha scelto la cucina. Non quella degli chef stellati, ma una cucina semplice, quella della tradizione, quella che unisce le famiglie e che si tramanda di generazione in generazione, di madre in figlio. Il racconto è un viaggio tra le cucine di un tempo, da quella tipica di Amelia, cittadina che ha dato le origini alla scrittrice, alla cucina kasher ebraica, passando però per quella delle antiche civiltà: romani, sumeri etruschi… Una cucina che si muove nello spazio e nel tempo.
Passato e comunicazione Le righe di Igea servono a recuperare il passato, a riattualizzare la memoria collettiva a partire dal singolo individuo che a ritroso deve comprendere la sua identità. Identità che coincide con la memoria stessa. Il cibo diventa così comunicazione. È un vero e proprio linguaggio, guidato da un codice essenziale. Come diceva Barthes, parole riportate anche dall’autrice in chiusura del suo libro, «Il cibo non è soltanto una collezione di prodotti, bisognosi di studi statistici o dietetici. È anche e nello stesso tempo un sistema di comunicazione, un corpo di immagini, un protocollo di usi, di situazioni e di comportamenti». Dunque il cibo diventa linguaggio sia per riscoprire noi stessi, la nostra identità e la nostra trasformazione culinaria, ma anche per entrare in contatto con gli altri.
Tradizione Una cucina della tradizione che ha portato Palombi a condividere con il pubblico alcune delle sue tradizioni familiari. A partire dalla sua infanzia, ha raccontato delle estati passate a Castelluccio e delle cene fatte con i paiolo sul fuoco, citando il camino, elemento centrale del libro e tanto caro a Igea. Ma non si è fermato qui. Ha raccontato anche quella che ormai è divenuta per lui una tradizione natalizia: regalare le lenticchie di Castelluccio. Un’usanza che aveva iniziato il padre e che lui ha voluto continuare. La parola è passata poi a Fatati che ha spiegato come il concetto di dieta mediterranea sia cambiato; ormai bisogna parlare di mediterraneità. Delineando così non più una dieta specifica, bensì una zona. La zona del Mediterraneo. E come questa zona è fondamentale, fondamentale è lo spazio cucina che però ormai non esiste più. Il dottore quindi ha ricordato come un tempo questo luogo fosse indispensabile non solo per il momento dei pasti, ma per tutta la vita. Era dove ci si riuniva e si stava insieme.
Le ricette Nel libro Igea ha inserito pochissime ricette. «Io non le volevo mettere», dice. E fa capire come il suo voleva essere un vero e proprio racconto di quello che era la cucina un tempo. Cosa voleva dire ritrovarsi tutti insieme intorno a un grande camino. L’autrice è una vera e propria enciclopedia vivente e non riesce, davanti a un pubblico così attento e curioso, a limitarsi al tema del suo libro e inizia a spaziare, mantenendo però sempre un collegamento con il tema centrale. Ed ecco che in pochi secondi, storia dopo storia, ci ritroviamo catapultati nel mondo della medicina, ma non quella di oggi, ma quella della Scuola medica Salernitana e delle credenze che si sono perpetuate negli anni. Igea spiega come non si andava dal dottore perché era la donna a curare i suoi malati, come era lei a comandare in casa e riporta le parole che le dicevano: «La donna in casa deve comandare, ma non deve farlo capire». Racconta così la storia di una donna che aveva tre chiavi legate alla cintura: una del cassetto della camera, dove teneva tutti i soldi guadagnati dal marito a cui poteva avere accesso solo lei, una della dispensa dove teneva il cibo che poteva toccare solo lei – era solo la donna a cucinare – e una della cantina dove c’era il vino, perché il marito non doveva ubriacarsi. Dopo aver raccontato le tradizioni a lei care ha lasciato la parola al marchese Marcello Aldega, presidente dell’omonima fondazione, che ha accompagnato i presenti in un excursus culinario all’interno delle opere d’arte.
La targa La presentazione del libro rappresentava solo la prima parte del pomeriggio. Infatti, a conclusione degli interventi, la parola è tornata a Urbani che ha premiato Igea con la targa ‘Donne ad alta quota’, un riconoscimento che viene dato alle donne che si sono distinte nel campo economico, sociale, culturale e che hanno contribuito ad arricchire e a far crescere il nostro territorio.